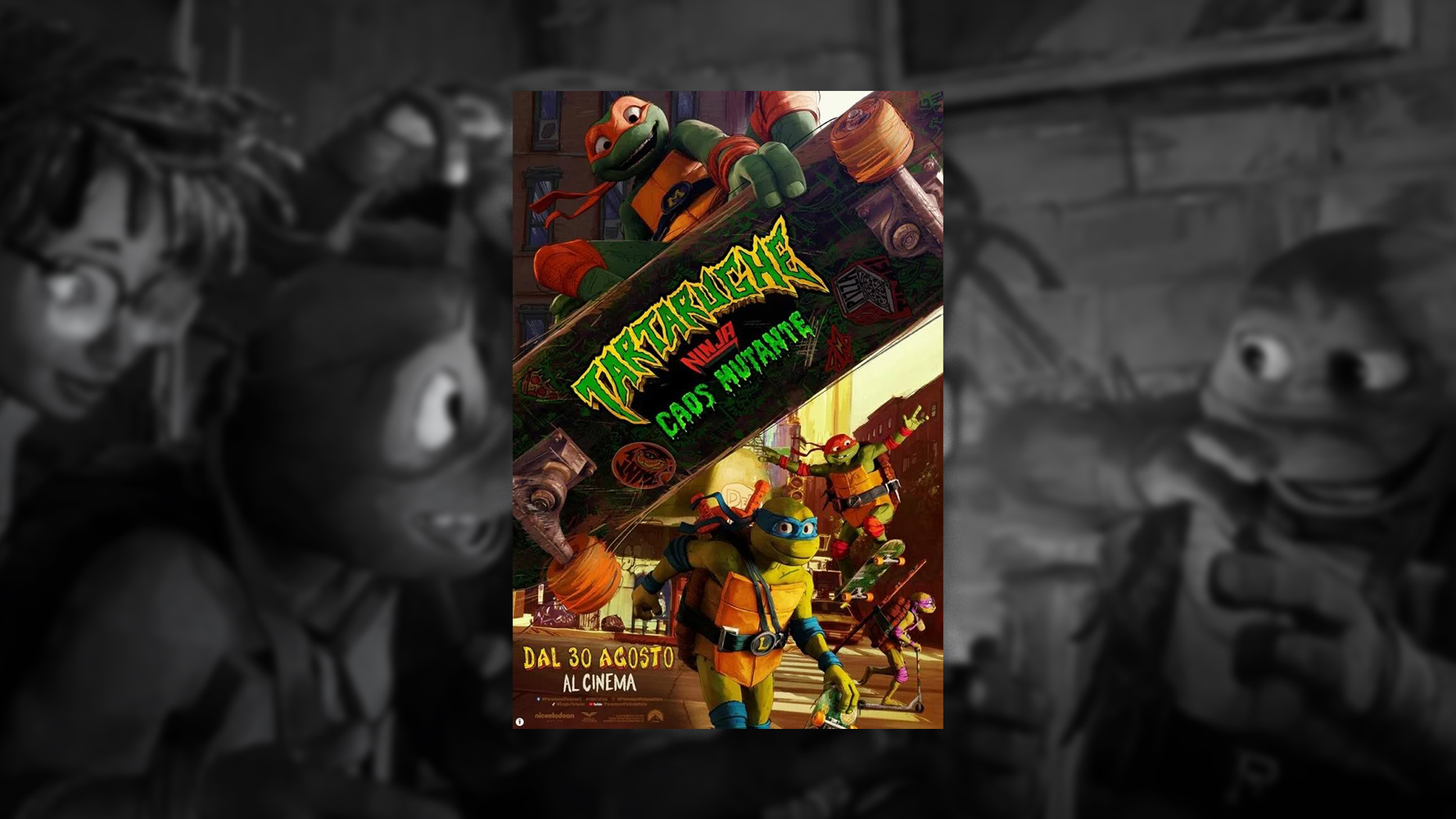Una storia per essere universale deve ispirarsi alla vita vera.
Peter Sohn
Sono queste le parole di Peter Sohn, regista di Elemental, film della Disney Pixar uscito nelle sale italiane nell’estate del 2023. Nato negli Stati Uniti ma di origini coreane, dopo la direzione de Il viaggio di Arlo Sohn decide di mettere in scena una storia più personale.
Siamo a Element City, metropoli dove tutti gli elementi convivono in armonia, o quasi. Ember Lumen è una “fuochese” che sta imparando a gestire il negozio del padre e sogna di sostituirlo nel ruolo, o così crede. La ragazza ha un temperamento alquanto “focoso” (scusate il gioco di parole) e finisce, senza volerlo, per causare una perdita dai tubi della caldaia nella cantina del negozio. Fa così l’improvvisa conoscenza di Wade Ripple, “acquatico” e ispettore delle infrastrutture, che fuoriesce per errore dalle tubature. È l’inizio di un’avventura: Wade si sente costretto a fare una segnalazione per le violazioni che riscontra nel negozio, Ember cerca di fermarlo senza successo ma cattura l’attenzione del ragazzo raccontando la storia di suo padre e parlandogli del sogno che il negozio rappresenta per lui. Wade decide dunque di aiutarla e portarla da Miss Cumulo, sua superiore, che acconsente a stracciare il rapporto solo a patto che venga chiusa una perdita del canale principale. Da questa collaborazione, l’acquatico e la fuochese scopriranno sempre più l’uno dell’altra, finendo per innamorarsi.

Il film si struttura su due temi portanti: quello della xenofobia e quello dell’amore. Sulla xenofobia possiamo dire davvero tanto: il film è costellato di elementi che portano il segno della vita del regista, figlio di immigrati coreani. Ed è proprio di questo che ci preme parlare, ovvero di come questa tematica sia messa in scena e cosa ci trasmette.
Partiamo da una chicca: la lingua parlata dall’elemento del fuoco (il Tsʼítsʼàsh) è stata creata ad hoc da David J. Peterson e Jessie Sams, coppia di linguisti e conlanger che hanno lavorato alla costruzione di linguaggi per diversi film e serie tv (un esempio, il Dothraki del Trono di spade, l’Hen Linge di The Witcher e il Chakobsa di Dune). Il semplice fatto che il lungometraggio si prenda la briga di costruire una lingua appositamente per un “popolo” è già di per sé un segno di inclusività (e non l’unico, visto che il personaggio di Lake Ripple è non binario). Le sfumature di essa ci vengono presentate nel corso dell’intera storia: attraverso le insegne del negozio dei genitori di Ember, nel linguaggio parlato all’inizio del film dagli stessi – specie quando si esprime la vicinanza alle tradizioni o l’amore genitore-figlia –, nelle espressioni come àshfá (per riferirsi al padre; unione forse di ash, ceneri, e father?) o bà ksô, la riverenza, forma di massimo rispetto che rappresenta un elemento culturale interno alla Terra del Fuoco, mostrando ancora l’attenzione del regista e del team per questo aspetto.

Il riferimento al tema dell’immigrazione è evidente anche da alcuni elementi di trama. All’inizio del film, vediamo arrivare i genitori di Ember in una barca che sta a galla a malapena, in contrasto con la metropoli che si staglia davanti ai loro occhi e ricorda tanto l’attuale New York (a cui effettivamente il regista dice di essersi ispirato, come meta di molti immigrati in fuga da paesi distrutti e in cerca di una vita migliore). Arrivati in città, vengono chiesti i loro nominativi, ma l’addetto che deve dargli quelli che sono evidentemente dei permessi di soggiorno non comprende la loro lingua, dunque opta per dare loro dei nomi nuovi, comprensibili a lui. Ci ricorda qualcosa? È l’incomprensione fra culture diverse, il prendere il nome di qualcuno e renderlo proprio, modificandolo. In qualche modo ci ricorda la scena de La città incantata di Hayao Miyazaki in cui Yu Baba ruba il nome a Chihiro, togliendole la sua identità. Vediamo anche gli abitanti rifiutarsi di vendere una casa alla coppia di stranieri, sentiamo la protagonista dire che «La città non è a misura di noi fuochesi» e notiamo la rappresentazione di una sorta di ghetto, un quartiere dedicato solo all’elemento del fuoco. Spezza il cuore la scena in cui Ember, ancora bambina, viene portata da suo padre a vedere una Vivisteria, l’unica pianta che può adattarsi a qualunque ecosistema, persino al fuoco. Quello che scopre, però, è solo il terrore di essere diversa. «Tornate alla terra del fuoco», «Bruciate a casa vostra». Sono questi i commenti e il contesto che vieta loro di entrare e coronare il sogno di una bambina: vedere una meraviglia che unisce, potenzialmente, tutti. Citiamo un ultimo elemento, sottile e che fa capire come anche chi cerca di allontanarsi dalla xenofobia ricada, magari senza rendersene conto, in un atteggiamento razzista. Ember si trova a un certo punto del film a cena con la famiglia di Wade, e qui lo zio del ragazzo le dice: «Devo riconoscere che ti esprimi in modo chiaro e corretto». Al che la ragazza risponde: «Già, è pazzesco come essere madrelingua possa cambiarti la vita». Un commento acido, ma che racchiude tutta la frustrazione di una diversità, di una distanza che sembra non riuscirsi a colmare. Almeno fino ai protagonisti.
La storia poi non è altro che questo, riuscire ad “alterare la nostra chimica”, come dice Wade a Ember, pur di toccarsi, pur di amarsi. Forse quello dell’amore che supera le barriere è un concetto un po’ abusato, ma sempre evergreen. Lo stesso Sohn, nel documentario Quando c’è chimica: la storia dietro Elemental – di cui consigliamo assolutamente la visione – dove parla dell’ispirazione dietro il film, dichiara che questa è una storia che vuole parlare dei gesti d’amore in un senso più ampio. Ammetto di essere scoppiata in lacrime quando il regista ha detto che era un omaggio ai genitori, ai sacrifici fatti per lui, all’importanza dei gesti in una cultura dove non si dice “ti voglio bene”, ma lo si dimostra. È nello scialle messo sul padre da Ember, nel farlo riposare e occuparsi del negozio. È nell’accettare di perdere se stessi, perché nessun gesto può ripagare un sacrificio se non fare lo stesso con i propri sogni. Ma è anche nel capire che il sogno stesso è la famiglia e che un genitore accetterà il figlio nel percorso che vuole seguire, anche se non era quello sperato. La luce che guida il percorso è quella espressa dalla protagonista: tishók, ovvero: «Alimenta la luce finché brucia, perché non durerà per sempre». È il seguire i propri sogni, viverli appieno, nonostante tutto, perché l’amore, quello vero, resta.

Ci sarebbero altri temi da esplorare: il divario sociale ed economico fra i due protagonisti (evidenziato dalla semplicità del quartiere di Ember e dallo sfarzo di quello di Wade, ma anche da alcuni dialoghi fra i due protagonisti), l’inclusività in toto, il simpatico omaggio alla studio Ghibli (il cui nome è stato dato a un personaggio che, fra l’altro, frequenta la scuola d’arte), ma anche allo stesso percorso del regista, l’importanza delle tradizioni, del portare con sé la propria cultura, espressa dalla presenza costante del fuoco blu nella famiglia Lumen. Li citiamo lasciandovi alla visione del lungometraggio animato.

Il film è chiaro, limpido. È l’invito a vedere oltre le differenze, a scoprire un mondo di amore nel senso vero, un amore di tutti per ogni essere umano, un amore che va oltre ogni diversità, di genere o di popoli. È il linguaggio universale, la storia che si fa mito a cui assurgere per dare linfa vitale a un mondo nuovo ed è quello che si propone di fare oggi l’animazione. Forse saremo un po’ melensi, ma in fondo desideriamo che questo mondo sia come la Vivisteria del film: si adatti a ogni luogo, a ogni elemento, sbocciando sempre nella sua meraviglia.
© Riproduzione riservata.
Il nostro giudizio


Nata a Palermo nel 1994, si diploma al Liceo scientifico Galileo Galilei della propria città. Prende una laurea triennale in Studi filosofici e storici e una magistrale in Scienze filosofiche e storiche all’Università degli Studi di Palermo, approfondendo in particolar modo gli studi antropologici di René Girard rispetto al capro espiatorio e agli stereotipi di persecuzione, oltre che al rapporto violenza-religione.
Potrebbe interessarti: