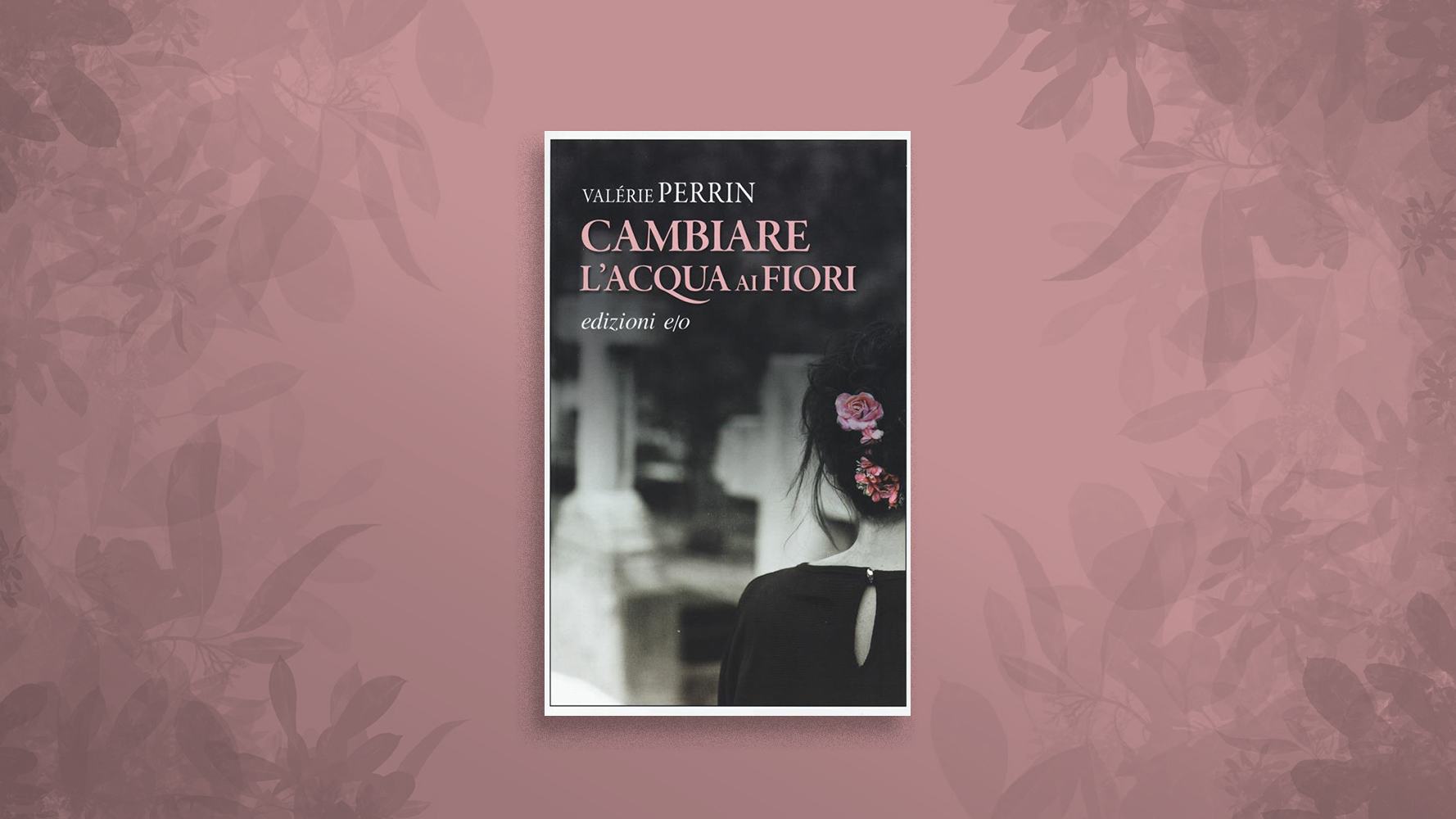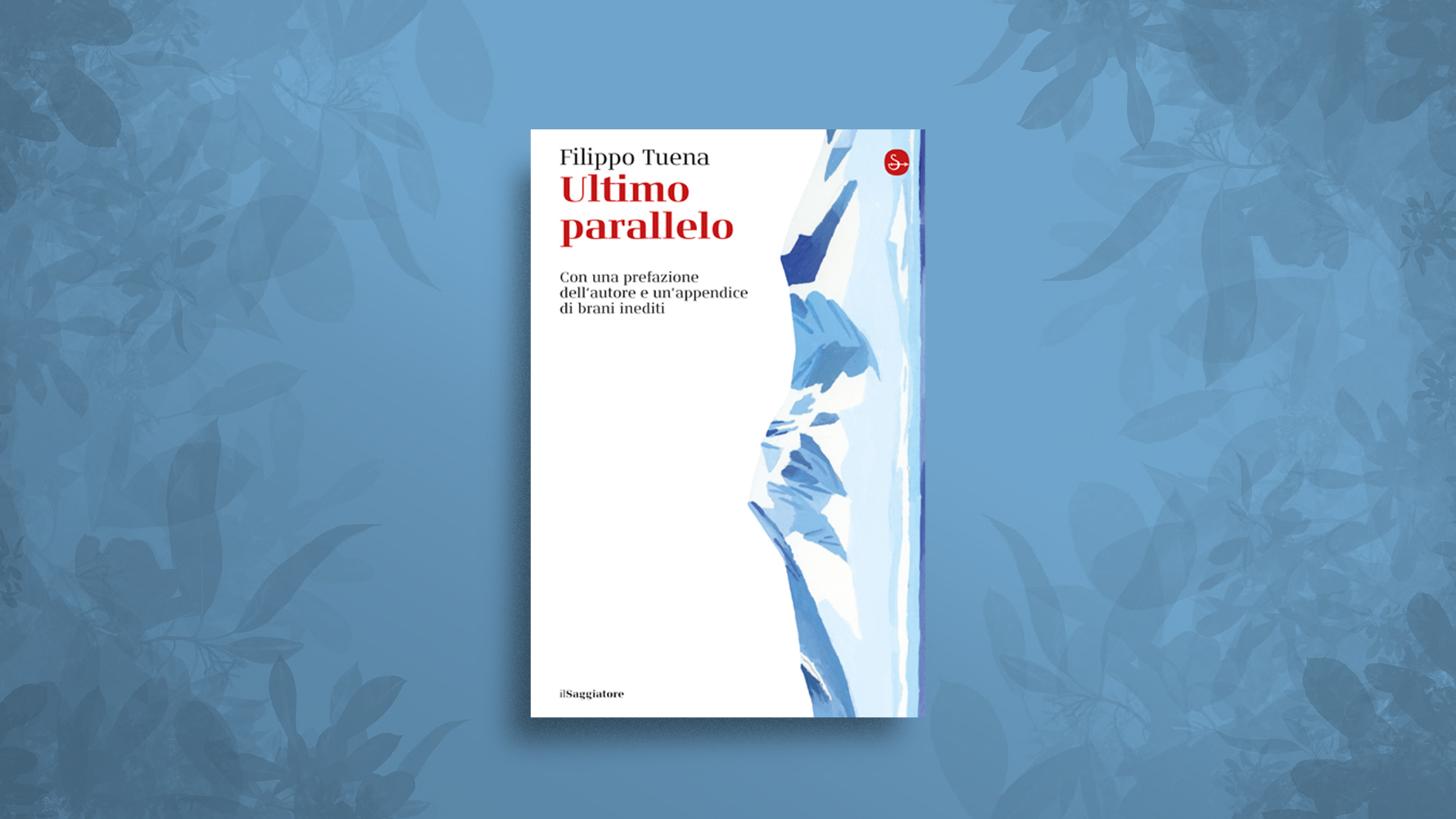Non so a chi appartenessi dal suo punto di vista. Se fossi umano oppure una cosa vivente. Anche se sono nato e cresciuto, e nei miei documenti c’era scritto essere umano, umano, qualcosa nel suo atteggiamento mi fece pensare che non mi considerasse alla pari, e per dei brevi, terribili secondi mi sentii artificiale, creato, nient’altro che una macchina umanoide di carne e sangue.
Che cosa significa essere umani? E che cosa significa essere vivi in un mondo in cui la vita stessa è governata dalla logica del profitto e della produttività? Dove si pone, in un mondo così fatto, la distanza fra risorsa economica ed essere vivente con la sua dignità inalienabile?
Oggi questo problema si fa sempre più pressante, laddove la sfera lavorativa invade le nostre esistenze e la società capitalista schiaccia l’essenza umana in un piccolo cubo fatto di poche facce, simulacri della nostra intera identità.

Olga Ravn, scrittrice danese nata nel 1986, si pone questi e altri interrogativi nel suo romanzo fantascientifico I dipendenti. Con una struttura polifonica, la trama si svolge attraverso le testimonianze dei dipendenti della seimillesima nave partita dalla Terra verso il pianeta Nuova Scoperta. La missione è quella di prelevare e accudire gli oggetti del luogo. Questi lavoratori, umani e umanoidi, vengono chiamati a descrivere il proprio rapporto con gli elementi scoperti da una commissione, inviata appositamente per indagare su alcuni strani avvenimenti in corso. Proprio le loro voci ci guidano alla scoperta degli accadimenti: i sentimenti contrastanti dei dipendenti che percepiscono le cose di questo nuovo mondo come vive, che provano intimità, desiderio o disgusto per esse. Tutto ruota intorno alla domanda che abbiamo posto prima: cosa significa essere vivi?
Per rispondere a questo interrogativo, la scrittrice pone i personaggi in una situazione estrema ed estranea: un ambiente chiuso, fatto di corridoi e piccole cuccette, senza alcuna via d’uscita. Qui gli esseri – umani e non – della nave scoprono un modo diverso di vedere il mondo che li circonda. Lontano dagli elementi della Terra, attraverso quegli stessi oggetti che sembrano rappresentare quasi delle “merci”, i protagonisti della vicenda riscoprono una sfera fondamentale del rapporto con le cose terrene: l’emotività. E non sorprende che siano proprio gli umanoidi a vivere questo insorgere di sentimenti come negativo: loro sono parte di un programma, un programma che li rende macchine da lavoro. Unico scopo della loro esistenza è lavorare. Ma sorgono improvvise domande nel rapporto con l’umanità, quesiti che ricordano anche a noi stessi che «Uno è più del lavoro che fa […] Uno non è soltanto il lavoro che fa»; ma, si chiede un umanoide, allora che cosa dovresti essere? Fuori da quel programma che ci ricorda il nostro vivere alienato, in un mondo in cui il valore e la dignità dell’individuo vengono assegnati sulla base di classifiche, qualifiche e soft skills, dove risiede più il nostro essere umani?

La domanda colpisce il cuore della nostra identità: dove sta l’io? Abbiamo assegnato l’onere della definizione a un sistema nominale e la questione ritorna in modo ossessivo nel libro. Essere vivi o umani non sono altro che ulteriori etichette, come quelle della produttività o del corpo. Essere carne, essere nati spontaneamente da un corpo che partorisce. Essere chiusi in una definizione binaria di genere: tutto ci riporta a quel piccolo cubo che è divenuto espressione del nostro io. Essere medici, essere architetti: la faccia della professione. Essere biondi, bruni, di pelle chiara o scura: la gabbia dell’esteriorità. E così via. Ogni cosa ci racchiude in un piccolo spazio, e ciò che avviene di noi è solo il divenire merce. In ogni ambito, siamo ormai prodotto di consumo, volto sui social, dipendente di un’azienda. Un insieme di definizioni che per loro stessa natura ci limitano. La libertà illusoria di poter essere qualunque cosa, ma sempre sotto un’etichetta.
Nel libro, sono tutti i personaggi a rompere il limite insito nella definizione, umani e umanoidi. Attraverso l’espressione della sfera emotiva, anche – ma non solo – nella forma amorosa, essi si proiettano fuori da sé e si domandano davvero quale sia la natura del proprio io. Rotto l’incanto del divertissement pascaliano (l’annichilirci nel mondano che riempie le nostre giornate), che non ci dà alcun tempo per porci domande, tolta la gabbia terrena, dove cercheremo questo io se non nelle cose del mondo e in noi stessi contemporaneamente? Le immagini del romanzo sono profondamente evocative, hanno il sapore di un ricordo dimenticato: gocce di pioggia, odori tenui o intensi, esperienze tattili così vivide che ci lasciano con il groppo in gola.

Una testimonianza in particolare è rimasta impressa a chi scrive: un umanoide afferra l’erba sperando di poter ricordare quella sensazione quando verrà ricaricata la sua coscienza in un altro corpo. Si chiede se quella percezione fisica rimarrà nella sua coscienza anche lontano da quell’involucro che ora abita. La domanda è ovvia: esistere al di là del proprio corpo, cosa può significare davvero? Questa identità che cerchiamo sembra rimbalzare per tutto il libro da un punto all’altro: il corpo, i ricordi, i sogni. Tutto questo sembra dire qualcosa sulla loro essenza, eppure non la esprime davvero del tutto. Gli umanoidi sono fatti di carne come gli umani, eppure non sono considerati umani: un nome, basta questo a cambiare il loro destino.
«Proprio nello stesso punto in cui la nostalgia della Terra dimora in lei, provo una nostalgia simile di essere umana, come se lo fossi stata un tempo, ma poi ne avessi perduto la capacità. Ora sono soltanto umanoide, ma non è la stessa cosa. Somiglio a un’umana e i miei sentimenti sono propri di un’umana, sono costituita dalle stesse parti. È questo che manca? Forse basterebbe modificare il mio stato nei vostri documenti? È una questione di nome? Posso diventare un’umana se mi chiamate così?»

Certo, sono prodotti artificialmente, ma vengono sviluppati, e si parla loro mentre stanno nelle incubatrici, come se si parlasse a un feto in grembo. Gli umanoidi non possono morire, certo, la loro coscienza viene ricaricata, ma viene anche volutamente modificata (ritornando alla necessità di ricordi per la costruzione dell’identità). E sorge spontanea l’ennesima domanda: allora sono davvero vivi? È vivo ciò che non può morire? Se sì, gli oggetti non sono altrettanto vivi? Queste questioni non hanno una vera e propria risposta, ma sono lasciate sospese dall’autrice.
Le testimonianze, come accennavo prima, sono varie, espongono punti di vista molto differenti: ci sono esseri umani che non riconoscono gli androidi come pari, che li concepiscono esclusivamente come macchine necessarie per lavoro; ma ci sono anche esseri umani e androidi che si amano a vicenda; ci sono androidi che vedono il proprio programma come ragione della loro esistenza e altri che cominciano a rifiutare gli aggiornamenti, rifiutano di far parte del sistema, reclamano la propria indipendenza come dei novelli Prometeo che sfidano gli dèi.

In sostanza, ritengo questo libro un grandissimo «sì, assolutamente da leggere». Impegnato, ma non impegnativo. Scorrevole, deciso. Va dritto al cuore dei problemi della nostra società alienata, costringendoci a un dialogo interiore sul significato della vita e sulla definizione delle nostre priorità. Ci pone di fronte al problema della morte, ma anche dell’eternità; dell’identità e del pericolo delle etichette. Ci mette faccia a faccia con la pressante domanda sull’evoluzione delle intelligenze artificiali e sulla sfera emotiva, che già da tempo pervade la letteratura e la cinematografia fantascientifica. E tutte queste domande le pone in modo nuovo, con la scelta di una scrittura frammentata in testimonianze, ma non per questo dispersiva. Siamo noi quei dipendenti alienati che avranno il loro risveglio nella “nuova scoperta”? O rimarremo macchine “obsolete” destinate alla propria terminazione, sostituite da una nuova generazione, da un’oltre-umanità più efficiente?
© Riproduzione riservata.
Il nostro giudizio


Nata a Palermo nel 1994, si diploma al Liceo scientifico Galileo Galilei della propria città. Prende una laurea triennale in Studi filosofici e storici e una magistrale in Scienze filosofiche e storiche all’Università degli Studi di Palermo, approfondendo in particolar modo gli studi antropologici di René Girard rispetto al capro espiatorio e agli stereotipi di persecuzione, oltre che al rapporto violenza-religione.
Potrebbe interessarti: